Realtà e visioni

C’è uno sguardo sulla realtà contemporanea che due autori, come Moretti e Filiberti, affrontano, partendo da osservazioni simili e giungendo a differenti conclusioni.
Tre piani di Moretti è un racconto tratto dalla storia di Eshkol Nevo trasportata da Tel Aviv in un condominio romano. Gente che si conosce, forse si stima, ma ciascuno vive una vita propria. C’è l’inesorabile giudice (lo stesso Moretti) con il figlio che guidando ubriaco uccide una donna e paga col carcere, tagliando poi i ponti con la famiglia. C’è il padre (Riccardo Scamarcio) ossessionato dal timore che l’anziano vicino gli abbia stuprato la bambina; c’è la donna fragile (Alba Rorhwacher), madre di una piccola, che ha il marito lontano al lavoro, in lite col fratello, e scivola verso una lucida follia. C’è una vasta solitudine esistenziale, rapporti difficili, rancori e incomprensioni, tradimenti e difficoltà a perdonare e a perdonarsi. E c’è lo sguardo dei giovani soli, dei piccoli che hanno bisogno di affetto da genitori smarriti, da adulti confusi e deboli. Il ritratto di un microcosmo che è però corale, denso, si fa macrocosmo.
Moretti è di fatto l’uomo che non capisce più il mondo in cui viviamo e in cui tutti siamo in qualche modo smarriti. Gli affetti restano (il rapporto profondo con la moglie, una bravissima Margherita Buy) ma poi c’è la morte, dopo la quale per il regista non c’è nulla ed anche il ricordo dei morti è un palliativo psicologico. Cosa resta in questo film dolente, misuratissimo, per nulla melodrammatico, ricco di spunti riflessivi e insieme sciolto e ben recitato da un cast corale? Forse un sorriso, quello di Margherita Buy che ritrova il figlio, mentre i figli delle altre coppie crescono e vanno verso la loro vita. Un tenue bagliore in una delle opere forse più belle e profonde del regista.
Di tutt’altro genere è “l’opera cinematografica” Parsifal di Marco Filiberti, intellettuale raffinato, un lavoro in 135’ che rilegge in maniera personale e forse autobiografica la leggenda cristiana del “puro folle” partendo da Wagner in una visione onnivora in cui musica, letteratura, arte, cinema, teatro e balletto -con colte citazioni – confluiscono in un poema fluviale, dal timbro “profetico”, post-cristiano e panteistico, quasi di una “nuova religione”. Fotografato splendidamente, il film racconta, osservando apocalitticamente l’attuale mondo “desolato”, il pellegrinaggio di Parsifal attraverso salti spazio-temporali (stagioni e giorni, Medioevo e l’amato Decadentismo fino agli anni Trenta del ‘900) dalla forza del desiderio (erotico) alla scoperta che il Graal è l’amore agapico, vissuto nell’”adesso” come possibilità di un “ricominciare”.
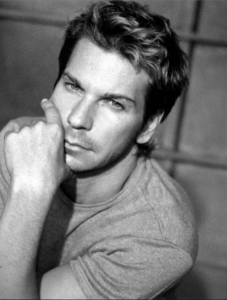
Lavoro ambizioso, unico nel cinema nostrano attuale, Parsifal si avvale in primo luogo della recitazione ben curata dal regista di un gruppo di giovani attori: il protagonista Matteo Munari, cangiante e maturo in un ruolo “difficile”, la virtuosistica Kundry di Diletta Masetti, Giovanni De Giorgi e Luca Tanganelli estroversi Palamede e Cador, le due donne “fatali” Elena Crucianelli e Zoe Solferino (il regista interpreta invece, teatralmente, sé stesso-Amfortas). In un’opera così densa e (troppo) lunga, sono inevitabili i momenti più o meno convincenti e riusciti.
La bellezza fotografica di persone e nature, luoghi e ambienti è reale, fascinosa, come la recitazione accurata e “scolpita” (troppo?) e alcuni momenti lirici, poetici, restano impressi, perché sono vitali. Tuttavia, la letterarietà alta dei dialoghi, il compiacimento estetizzante dei corpi (ci sono scene forti: necessarie?), certo senso patinato della scenografia rendono difficile la comprensione del messaggio, anche perchè la parte “terrestre” appare più riuscita e convincente di quella “mistica”. Il tono “profetico” rende l’opera un lavoro difficile per il pubblico che non sia d’élite, magari voluto dallo stesso regista.
Il risultato è che se Moretti forse potrebbe salire ad una visione meno affranta della vita, Filiberti potrebbe scendere a immedesimarsi in essa per arrivare a tutti. Per entrambi i registi il percorso non è concluso.
