Nonostante tutto, ci crediamo
La difficile situazione degli atenei italiani sta incidendo negativamente sulle prospettive dei giovani neodiplomati, che però non mollano.
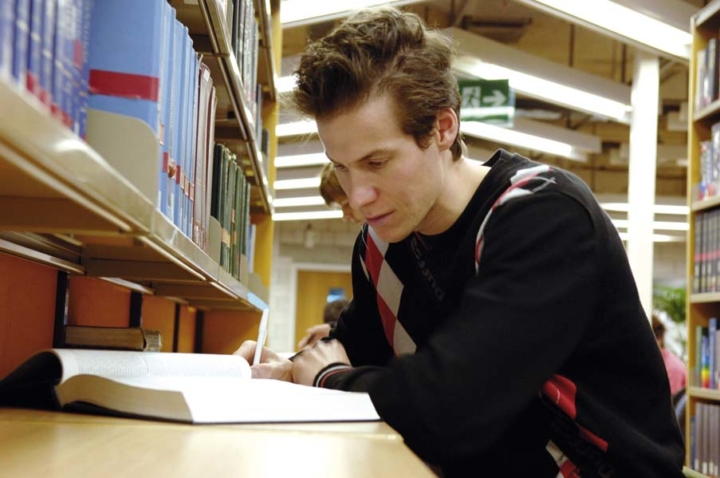
Finiti gli esami, è tempo di iscriversi all’università. Scelta pressoché ovvia nel caso dei licei, in cui la quasi totalità dei maturati prosegue gli studi, e che tocca invece solo il 27 per cento di chi ha scelto la formazione professionale. Ma non sembra il momento migliore per entrare negli atenei. Tra tagli all’istruzione e retorica più o meno disfattista sulle condizioni dell’università italiana, la scelta di farla finita con i libri può apparire giustificata.
I ricercatori, a cui è affidato oggi il 40 per cento della didattica, hanno annunciato che ad ottobre incroceranno le braccia: il rischio che molti corsi non partano è concreto. Secondo il piano “Italia 2020”, pubblicato dai ministeri dell’Istruzione e del Lavoro, l’Italia è l’unico Paese europeo in cui il tasso di disoccupazione è più alto tra i giovani laureati (11,2 per cento) che diplomati (8 per cento), i cui profili professionali sono spesso più rispondenti alle esigenze del mercato (il ministero del Lavoro stima una carenza di 180 mila tecnici intermedi). Diplomati che, nel 42 per cento dei casi, guadagnano più di mille euro al mese: se alla lunga la laurea paga, sul breve periodo pare di no, dato che, secondo l’indagine 2009 del consorzio Almalaurea, lo stipendio medio a un anno dal conseguimento del titolo è di 1.036 euro, per passare a 1.130 dopo tre e 1.320 dopo cinque.
Insomma, chi ce lo fa fare: e ci sarà pure un motivo se in Italia, Paese in cui – sempre secondo i dati ministeriali – oltre il 60 per cento dei giovani si immatricola, solo il 40 per cento di questi arriva alla meta. Aggiungiamoci poi la frustrazione di doversi accontentare, in poco meno della metà dei casi, di un lavoro non attinente al proprio titolo (record europeo anche qui). I dati sulle iscrizioni degli ultimi due anni sembrano confermare questo quadro: gli atenei pubblici hanno visto un calo del 2 per cento, mentre quelli privati – forse visti come “rifugio”, almeno da chi può permettersi la retta – un incremento del 10. Ma davvero i giovani ragionano così?
La realtà, come sempre, è assai più sfaccettata. «Per quanto ultimamente la mannaia stia scendendo un po’ troppo sulle nostre teste – afferma, ad esempio, Marco, che ha appena concluso il liceo scientifico –, dopo un’esperienza di studio all’estero rimango comunque convinto della validità del sistema italiano. Ho scelto di iscrivermi alla facoltà di economia a Venezia, che offre anche corsi in inglese, il che mi sembra particolarmente interessante».
In barba alle classifiche internazionali che relegano tutti gli atenei italiani oltre il 174° posto ottenuto da Bologna, gli studenti del Bel Paese non sono tuttavia così pessimisti: «Dopo cinque anni di ingegneria dei materiali – conferma Paolo, studente a Padova –, posso dire che la qualità dell’insegnamento è buona. Più carente, come risaputo, è la possibilità di toccare con mano quanto si studia: alcuni laboratori sono stati strutturati in modo che noi fossimo solo spettatori».
Nulla di nuovo sotto il sole quindi: anche il rapporto ministeriale torna più volte sulla necessità di un collegamento tra atenei e mondo del lavoro che vada oltre l’abusato stage. Nessun rimorso, comunque: «Ho scelto di iscrivermi all’università – prosegue Paolo – sia per interesse personale, sia perché il liceo scientifico non dà sbocchi specifici. Rifarei lo stesso oggi, nonostante i problemi maggiori che ci sono».
L’atteggiamento prevalente sembra essere il “nonostante tutto, ci crediamo”. Anche la fuga verso gli atenei esteri, per quanto in crescita, non assume infatti proporzioni bibliche: nel 2007/08, per poco meno di 2 milioni di iscritti nelle università italiane, circa 41 mila studenti hanno scelto di fare le valige, contro i 38 mila del 2005. D’altra parte, secondo i dati Censis del 2009, le università italiane ospitano 51 mila studenti stranieri, il cui numero è raddoppiato nel 2007/08: la tendenza alla mobilità internazionale non è quindi limitata al nostro Paese, per quanto fortemente indirizzata verso mete come gli Stati Uniti, scelte dal 20 per cento di chi decide di spostarsi oltre confine.
Insomma, è ancora presto per suonare il requiem dell’università italiana, la cui forza sta soprattutto in chi ci studia o ci lavora: «I nostri rappresentanti – commenta, infine, Paolo – stanno raccogliendo esperienze per migliorare la situazione in futuro».
