Nei caruggi del centro storico di Genova
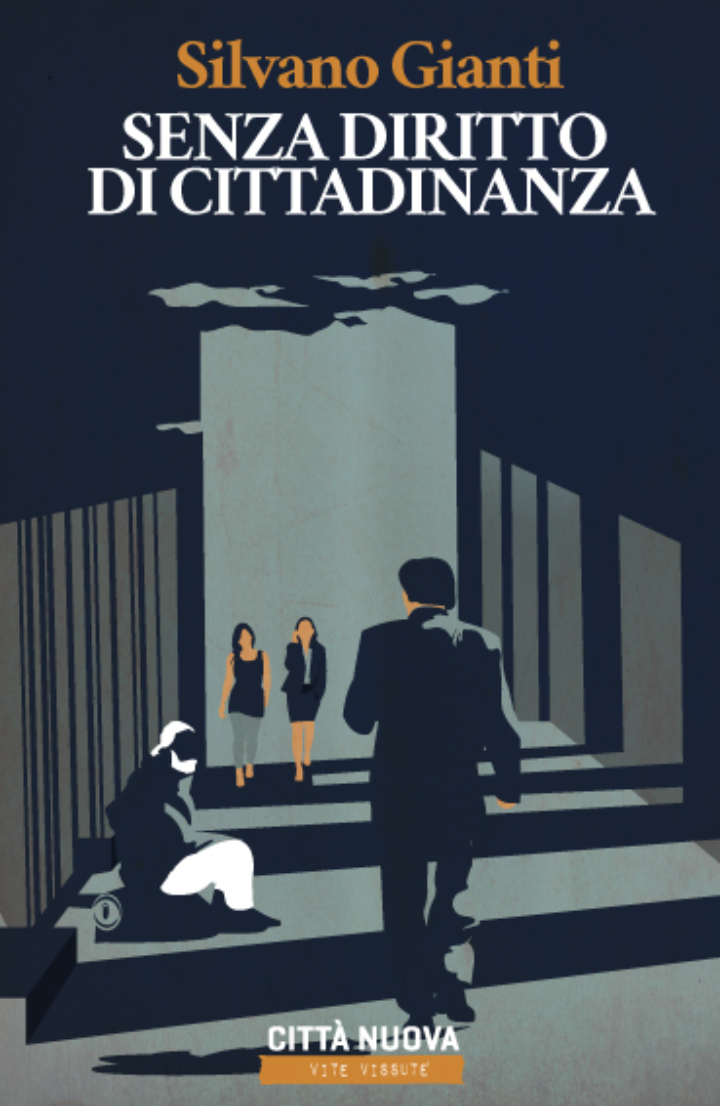
La giornata inizia di buon mattino per chi deve lavorare e portare a casa qualche spicciolo per far mangiare i propri figli. E inizia in mille modi. Ma per chi cerca di arrivare a sera avendo racimolato qualche euro, la zona di Caricamento sotto la Sopraelevata, la strada che passa nella zona del Porto Antico di Genova all’altezza dei tetti delle abitazioni, è un luogo importante. Qui, tra il parcheggio degli scooter e quello delle auto, si svolge un commercio variegato, di mercanzie provenienti da ogni luogo. Jeans, camicie e scarpe, usate e nuove, rubate o ricevute in beneficienza, e poi cibo e spezie, radio e cellulari, tutto viene venduto pur di far cassa. Ogni cosa è esposta su teli posati a terra, in modo che al primo avvistamento di una qualche pattuglia della Polizia o della Guardia di Finanza, in quattro e quattr’otto si possano piegare i quattro lembi del telo e il fagotto è pronto. Alla velocità della luce, lo spazio torna a essere completamente libero. Tutto sparito. Per poi riapparire poco dopo, nuovamente lì. Un rito che si ripete tante volte al giorno, un rito che però non ha nulla di trascendente. È invece l’esposizione della desolazione e della sofferenza di chi è arrivato dagli angoli più remoti e più poveri del mondo, con la speranza di poter vivere dignitosamente, ma che purtroppo arrivando qui ha solo aggiunto altra povertà alla sua già misera esistenza.
Perché se, da una parte, Genova mostra al passante le meraviglie del centro storico più grande d’Europa e i suoi affascinanti “caruggi”, dall’altra non può nascondere quelle zone off limits, che esistono, eccome! Vere sacche di povertà e disperazione, di abbandono umano e morale. E, proprio dove il Porto antico s’incunea nel centro storico, si estende appunto una delle tante periferie esistenziali della città. Inizia da questi luoghi o termina in questi luoghi, a seconda di come la si vuole vedere, ed è fatta di persone ai margini, mescolate con altre che vivono serene e tranquille, alcune anzi nel più grande benessere, in una città con yacht da trenta metri ormeggiati alla banchina accanto agli immensi magazzini di cotone.
Più avanti c’è un altro assembramento di emarginati, a lato di Palazzo San Giorgio, con i suoi portoni aperti sul mare e la scalinata che scende fino ai binari della metropolitana. Altri “randagi”, spenti come le lampare delle barche durante il giorno, guardano immobili chi passa loro accanto. Un folla amorfa che aspetta passivamente che qualcosa accada, come carta di giornale ammucchiata ai crocicchi dei caruggi, pronta a volare via alla prima folata di vento. Da queste parti se leggi i nomi sui campanelli delle abitazioni trovi tanti Abdullah, Mohamed, Mustafà, Hassan, Said. Seguono poi nomi cinesi, africani, dell’Europa dell’est.
Guardando meglio, si scoprono le targhe di numerosi ambulatori medici, di centri di ascolto, di vere e proprie scuole di inculturazione dove si fa doposcuola ai bambini e si insegna la lingua italiana agli adulti, e alle donne perfino a cucinare i piatti di questa terra, affinché magari trovando lavoro come badanti, se la sappiano cavare anche come cuoche. Ma non basta, la diffidenza e la paura restano. E le strade sono piene di persone che ciondolano tra le case, guardando smarrite in avanti. Ma dove? Le periferie non sono solamente luoghi fuori dal centro della città, lontani dal potere e dagli apparati decisionali. Sono anche luoghi lontani dal più profondo dell’umano che è accoglienza, solidarietà, giustizia. Periferie dell’anima, insomma, dove è assenza di luce e di senso, dove spesso si vive all’ombra del male morale e del degrado sociale. Come da altre parti della città, ovviamente, ma qui è tutto più marcato.
Città contraddizione appunto, elegante nelle sue piazze trionfanti e puzzona nei suoi angoli più crudi, dove il fascino della città borghese si mescola al sudore dei “camalli”, dei pescatori del mercato, degli operai a ore. La sua bellezza è tutta lì, tra il profumo di mare e il fritto di pesce. Insomma, Genova s’è fatta davvero bella negli anni, s’è rifatta il look, ma è pur sempre una città di mare, al cui molo approdano i disperati in arrivo, i clandestini di ogni dove. I suoi caruggi li ho attraversati dieci, cento volte per centinaia di giorni, li conosco come le mie tasche. Nel bagno di folla che sfiora il mio quotidiano camminare è impossibile fare a meno di interagire, di porre domande e avere risposte. E ogni volta che ho potuto mi sono fermato a parlare con la gente per strada. Tutta la gente, perché l’umanità è sempre interessante. Quando ho dovuto scegliere, però, ho cercato soprattutto quella ai margini, perché c’era un debito da pagare. Un debito di tempo e di attenzione, personale e allo stesso tempo universale, o, forse, semplicemente umano. Perché in fondo non sappiamo accogliere la diversità, anzi spesso abbiamo contribuito noi stessi a crearla, ma soprattutto perché sempre, evitandola, disconosciamo la natura complessa della nostra stessa esistenza.
Anche per questo ho conosciuto Babatunde. Tra lo schiamazzo di turisti appena scaricati da un pullman e tre operai che effettuavano l’ennesimo scavo attorno a un allacciamento del gas, lui stava allestendo il suo banchetto di occhiali da sole e custodie per telefoni cellulari. L’odore del pesce che proveniva dai banchi del mercato era intenso, come quello del fritto che fuoriusciva dai locali affacciati sulla strada. Babatunde aveva alzato il banchetto e raccolto gli occhiali che il vento gli aveva buttato a terra per ben tre volte in una manciata di minuti. Ero rimasto a guardarlo, incuriosito dai suoi movimenti lenti e armoniosi che contrastavano con la fretta sgraziata dei passanti. Dopo un po’ mi aveva sorriso e chiesto se volevo degli occhiali. Gli avevo detto di no, che ho bisogno di lenti speciali, ma che comunque la sua merce era molto bella. Non credo che gli occhiali gli interessassero molto. Forse aspettava solo l’occasione di poter parlare perché subito aveva iniziato a raccontarmi la sua vita. Era arrivato tre anni prima in Sicilia, senza documenti, senza denaro, senza famiglia, perché Babatunde era il capo e quindi doveva venire in Italia per primo, trovare di che vivere, lui e la famiglia, e finalmente portare qui la moglie Isoke e i suoi tre bambini Ndasuunye, Tomi e Kalifa. Non avendo però trovato lavoro nell’isola, si era spostato più a nord, sulla costiera salernitana, a un passo dal Cilento. Una lunga strada dritta dove gli stranieri come lui vivono tra campi e serre da un lato e il bosco dall’altro, in una promiscuità deprimente, lavorando come somari per sei giorni alla settimana e ciondolando nullafacenti il settimo giorno lungo quella stessa strada, dove alla luce del sole gli uomini si ubriacano e le donne si prostituiscono, magari solo per avere un po’ di compagnia.
Babatunde aveva raccolto pomodori per una stagione, poi era nuovamente rimasto disoccupato. Durante l’estate si era spostato sulle spiagge della regione, dove aveva potuto vendere sotto il sole cocente d’agosto oggetti di artigianato africano, creme abbronzanti e dopo sole, cocco fresco e occhiali. Purtroppo c’erano i “caporali”, a controllare il suo lavoro, a dirgli cosa fare, a minacciarlo se non vendeva o anche solo se si fermava a parlare troppo con la gente. Una vita tremenda, in ogni senso, soprattutto perché aveva perso i contatti con la famiglia in Africa. Sognava spesso sua moglie e i suoi bambini, piangendo talvolta per la nostalgia e per la paura di ciò che poteva accadere loro, anche se c’erano i suoi parenti a proteggerli e di certo non sarebbero rimasti soli.
Infine, dopo l’estate aveva risalito la penisola ed era arrivato a Roma, dove finalmente aveva potuto ricevere ospitalità presso la Caritas. Il suo sogno, però, non era certo quello di farsi assistere da un ente benefico, era venuto in Italia per mettere su un’attività dignitosa. Aveva insistito su dignitosa, «perché sono un essere umano, che è andato via dal proprio paese solo per poter far stare meglio la sua famiglia», anche se alla fin fine ora stavano tutti peggio. Da un po’ di tempo era arrivato a Genova, risalendo la spiaggia a tappe, regione dopo regione, un po’ di mare e un po’ di treno. Diverse volte la polizia gli aveva sequestrato la merce. L’ultima volta, racconta, gli avevano portato via abiti per oltre trecento euro. Ora, però, era qui e vendeva nuovamente occhiali. Certo, la storia non era cambiata granché, tuttavia un pasto caldo lo aveva ogni giorno, come anche la possibilità di sentire la famiglia. «Li ho scongiurati – aveva concluso – di non venire in Europa, di restare in Africa e accontentarsi di quanto hanno». Parlavamo ancora mentre una signora si era avvicinata e aveva preso un paio di occhiali in mano. «Quant’è?», aveva chiesto. «Quindici euro», aveva risposto con un bel sorriso Babatunde, il prezzo di un paio di occhiali di marca contraffatta. La signora aveva messo mano al borsellino e li aveva comprati, infine lo aveva salutato, allontanandosi con il suo nuovo acquisto.
Occhiali per ripararsi dal sole, che ora picchiava sul muro del palazzo alle nostre spalle e forse riscaldava un poco la fredda mattina del mio amico africano.
Da Senza diritto di cittadinanza di Silvano Gianti, pp. 112; € 13,00
