Aldo Masullo: “Lo straordinario nell’ordinario”

“Napoli e un sogno condiviso”1: cosi titolava “il Mattino” un articolo di Aldo Masullo, professore emerito di Filosofia Morale alla Federico II di Napoli, nonché amico che ha condiviso il dialogo con persone di convinzioni non religiose, promosso dal Movimento dei Focolari.
Vogliamo ricordare alcuni momenti vissuti con lui, ma soprattutto frammenti del suo pensiero, sempre illuminanti.
Egli amava molto la turbolenta e fascinosa città di Napoli, e volle condividere con noi le ansie, le difficoltà, qualche volta la nostra rabbia, e sognarla insieme diversa, per contribuire alla trasformazione di una realtà ribollente di forze che si contrastavano, di pericoli, in una Napoli senza troppi rischi, fatiche, pericoli o perdite di tempo «perché il tempo è la vita e possiamo insieme riuscire a governare il tempo, riuscire a risparmiare gli sprechi, riuscire a fare di ogni momento un momento straordinario, in quanto lo straordinario sta nell’ordinario».
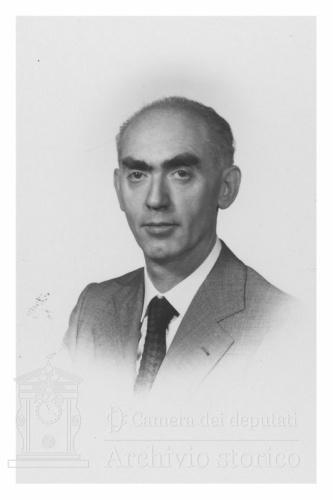
Ci ritrovammo insieme, un giorno, nel lontano 2006, al cinema Modernissimo di Napoli con tanti studenti, per vedere il film Fuoco su di me del regista Lamberto Lambertini. Pur nell’ordinarietà di quel momento, lui disse di aver vissuto “un’esperienza straordinaria” in quanto non era stato un incontro convenzionale, ma un incontro in cui ognuno aveva cercato di capire insieme con gli altri qualcosa di più della realtà: «Condividendo interrogativi e riflessioni abbiamo trasformato la nostra ordinarietà in straordinarietà, e abbiamo fatto del sogno una realtà condivisa da vivere come cittadini, come napoletani».
Sapevamo tutti, da alcuni fatti dolorosi che Napoli in quegli anni aveva vissuto, che Aldo Masullo aveva sofferto nel sentire parlare negativamente della sua città, e lo confermò quel pomeriggi a tutti noi, sorprendendoci subito dopo affermando che, come avveniva nel film, “il segreto” di Napoli era proprio nella gentilezza, precisando che la citta non appariva gentile perché più delle altre città manifestava i limiti del nostro tempo, limiti che insieme dovevamo arginare e sconfiggere.
Essere gentile, precisò Masullo davanti a quella platea di giovani, non significava mostrarsi deboli, come tanti vorrebbero intendere, ma «possedere quella forza d’animo che non ha bisogno della violenza per affermare la verità; è gentile colui che è capace di parlare con gli altri a cuore aperto, di ascoltare gli altri, anche quando dagli altri ci viene soltanto un sussurro che noi dobbiamo amplificare con la nostra intelligenza, con la nostra attenzione, con la nostra umanità. Solo allora ci rendiamo conto che la gentilezza è una chiave per superare la crisi del nostro tempo. Gentilezza che include anche la tenerezza, valore non solo femminile, ma che vive in quel femminile che è in ciascuno di noi uomini, così come anche il maschile vive nelle donne. Noi siamo sempre portatori delle due metà dello spirito, e siamo veramente uomini quando riusciamo ad ascoltare dentro di noi anche la voce della tenerezza, che è la voce per eccellenza delle donne».
Poi rivolgendosi proprio ai giovani aggiunse: «Tra questi due termini, gentilezza e tenerezza, si pone il problema politico delle masse, dei quartieri di Napoli, senza la soluzione del quale nessun problema si risolve, in quanto è fondamentale trovare dentro di noi la radice più profonda della vita e la capacità di fare della vita un cammino, non sempre facile, verso quella nuova umanità che tutti attendiamo e che vede giovani e adulti insieme».
E fu a questo punto che egli lanciò a tutti noi una sfida: saldare la continuità tra le vecchie generazioni e le nuove. «Senza questa saldatura la nostra società è destinata a perire…Se noi vecchi non riusciamo a dialogare con i giovani non siamo altro che dei ricordi. Se i giovani non cercheranno il rapporto con noi vecchi verrà meno la progettualità per il futuro. Solo nel dialogo tra le generazioni la società può vivere realmente, non dico sopravvivere perché c’è in questa parola già un senso di decadenza».
Ed invitò noi tutti a intraprendere, giovani e adulti, la strada del dialogo, un dialogo di comunione, pur nella diversità: «Non si vive di rendita, ma si vive arricchendoci ogni giorno mentalmente. Anche moralmente non si vive di rendita: se non continuo a studiare io divento uno stupido, se non continuo a dialogare con i giovani io divento un pensiero arido, se non mantengo un rapporto con la realtà che sempre si rinnova, io sono un cadavere che cammina…Per esser vivi bisogna scegliere di comunicare con l’altro da sé».
Aldo Masullo, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, in tutte le sedi dove ha continuato ad andare, strenuamente, fino a quando le forze glielo hanno permesso, ha sempre cercato di dare una risposta alla domanda: come realizzare un giusto rapporto tra i giovani e gli adulti?
Riteneva lo scontro tra adulti e giovani un grande pericolo, un punto di frantumazione della società, uno degli aspetti più problematici. E si domandava sempre: «Ma in realtà cosa vogliono entrambi? Vogliono la pace e non la guerra!». E di conseguenza l’unica strada da percorrere era quella capacita di entrare in dialogo con l’altro, non di opporsi all’altro per dominarlo. Il dialogo come strada maestra quindi per costruire ovunque fraternità, in quanto ogni uomo è portatore della propria singolarità della propria visione, del proprio punto di vista, e l’umanità realizza il suo essere non nello scontro dei diversi punti di vista ma nel porli in dialogo, nel confronto, nell’arricchirli reciprocamente.
Come filosofo, inoltre, ma anche dopo aver vissuto esperienze nel Parlamento italiano sia alla Camera sia al Senato, volle sempre sottolineare la necessita di curare e difendere la democrazia, consapevole che essa prima di essere un fatto di tipo politico formale era un fatto culturale.
Quindi grande attenzione nel formare i giovani a vivere democraticamente e a farsi carico dei bisogni vitali gli uni degli altri, intravedendo nella scuola la possibilità reale di portare avanti i principi fondanti di una democrazia attraverso il dialogo e il lavorare insieme come unica strada per giungere un domani alla fraternità universale nella pace. «L’essere umano è come un pesce in ambiente acquatico. Se l’ambiente è povero il pesce rimane povero, se l’ambiente è ricco allora il pesce diventa grosso e pieno di qualità. Noi oggi possiamo dire di essere pesci abbastanza grossi perché l’ambiente in cui nuotiamo è abbastanza ricco di alimenti, di fermenti. Per cui se prima non essere soggetto collettivo non costituiva una colpa perché risultato di una privazione, oggi non essere soggetto collettivo è una nostra responsabilità, perché ognuno di noi può muoversi e stimolare questo soggetto collettivo, può unirsi agli altri e lavorare insieme per una cultura di pace».
Quando nel 2009 al Centro la pace di Benevento ascoltammo insieme il discorso sulla fraternità che Chiara Lubich aveva tenuto a Roma alla II giornata dell’Interdipendenza nel 2004, egli condivise pienamente quel sogno ritenendolo necessario seppur difficile. E realisticamente aggiunse: «Quando per circostanze varie, nonostante il nostro impegno, dovessimo vedere quel sogno svanire, dovremmo continuare a sperare, perché quel sogno è stato da noi vissuto e nel suo fallimento c’è il suo trionfo, pagato dalle nostre scelte, dalla visione di un grande ideale non ancora raggiunto».
Alla domanda postagli sull’educazione dei figli, in una realtà come la nostra in cui trionfano coloro che hanno pochi scrupoli, che preferiscono tante volte la corruzione alla virtù, egli così rispose: «Capisco il dubbio che può insinuarsi in noi, il dubbio che educarli ad essere virtuosi li educhiamo ad essere sconfitti…Ma bisogna scacciare questo dubbio. Ai figli, ai giovani tutti – perché tutti i giovani sono miei figli, ogni generazione è figlia della precedente -, bisogna parlare con onestà, con chiarezza. Non vi illudete che l’amore, la gentilezza trionfino sempre e subito, però sappiate che l’amore e la gentilezza hanno un valore superiore a tutto. Sta a voi scegliere. Ai miei figli ho cercato di mostrare gli aspetti positivi e negativi di ciascuna delle due vie. Ognuno poi dovrà scegliere da sé. E questo, credo, sia la più forte affermazione della libertà dell’uomo, perché libertà consiste semplicemente nel cominciare da sé».
Quanti saranno oggi disposti ad affrontare la vita il tal modo? Masullo ci mise tutti nella serenità dicendoci: «Non importa quanti. Importante è scoprire le carte. Io credo che la vita sia un gioco e una scommessa, un gioco e una scommessa in cui il vero premio sia il trovare o ritrovare se stessi. L’identità non ci viene da fuori, il riconoscimento non ci viene dall’esterno. Il riconoscimento ci viene dal nostro interno, quando ci rendiamo conto che se il sogno è stato sì sconfitto sul piano della cronaca, quel sogno vissuto con onestà e passione vive con noi. Anche se noi fisicamente moriamo quel sogno vive al di là della nostra stessa vita fisica. Solo colui che ha avuto la fortuna di riconoscere la virtù nell’eroismo morale, nell’eroismo della lotta contro i demoni, nell’eroismo della fedeltà a se stessi e non solo nelle battaglie, potrà scoprire che la virtù coincide con la felicità. È il grande tema di tutti i filosofi morali, e come non c’è virtù senza felicità, non c’è felicità senza virtù»
Aldo Masullo nasce ad Avellino nel 1923 e muore a Napoli nel 2020. Filosofo e politico ha insegnato all’Università di Napoli come professore di filosofia teoretica e poi di Filosofia morale.
Dal 1984 al 1990 è stato direttore del Dipartimento di Filosofia della Federico II e Medaglia d’oro per la Pubblica istruzione. Molte le sue pubblicazioni. Tra queste “Strutture soggetti e prassi” nel 1962, “La comunita come fondamento” 1965, “Metafisica, storia di un’idea” 1980, “Il tempo e la grazia-Per un’etica della salvezza” 1995.
1 Aldo Masullo, Napoli e un sogno condiviso, Il Mattino, Napoli 27 aprile 2007
